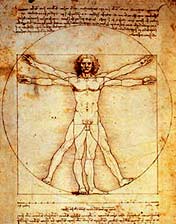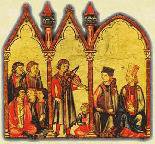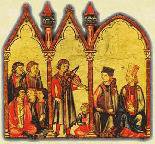
La nuova
lingua d'oc diffusa nelle province della della
Francia meridionale acquistò dignità letteraria grazie ai
trovatori. Nei versi delle loro poesie comparivano valori come
l'amore cortese caratteristici di quel tempo. La poetica più comune fu la
cansó, divisa in strofe o stanze (coblas) aveva una struttura simile a quella degli inni. Altre forme furono i sirventès, il planh, la tenso o joc parti, l'alba, la pastorela, i ductia e le estampida. Tra gli stili ricordiamo: il trobar plan o trobar len, il trobar lic e il trobar clus.
Friedrich Gennrich, un
musicologo tedesco,
ha diviso la produzione musicale trovadorica e dei trovieri in quattro forme-tipo musicali: il
tipo litania (ripetizione di una stessa formula melodica con possibile alternanza tra coro e solista), il
tipo lai-sequenza (ogni frase era ripetuta prima di passare alla successiva), il
tipo inno (formato da strofe con stessa struttura metrica e stessa melodia), il
tipo rondeau (il ritornello corto ripetuto dal coro si contrappone ad una o più stanze di maggiore ampiezza). Oggi conosciamo il nome di circa 450 trovieri, oltre 2600 testi poetici e appena 350 melodie.
I più importanti trovatori furono: Guglielmo IX, Ebolo II, Marcabruno di Guascogna, Jaufré Rudel, Bernard de Ventadorn, Arnaut Daniel, Guiraut de Borneilh, Rainbaut de Vaqueiras, Peire Vidal, Folquet di Marsiglia e Uc de Saint-Circ.
 Durante tutto il Cinquecento i migliori cantori erano quelli avevano studiato nelle maggiori cantorie della Fiandra. I compositori fiamminghi furono i maggiori del secolo, un esempio fu Orlando di Lasso (ritratto a sinistra)(Mons 1532 – Monaco di Baviera 1594). Altri, invece, diventarono capiscuola di nuovi orientamenti musicali, come Adriano Willaert (Bruges 1490 ca. - Venezia 1562).
Durante tutto il Cinquecento i migliori cantori erano quelli avevano studiato nelle maggiori cantorie della Fiandra. I compositori fiamminghi furono i maggiori del secolo, un esempio fu Orlando di Lasso (ritratto a sinistra)(Mons 1532 – Monaco di Baviera 1594). Altri, invece, diventarono capiscuola di nuovi orientamenti musicali, come Adriano Willaert (Bruges 1490 ca. - Venezia 1562).